Infermieri. Dal ruolo centrale nella gestione dei disturbi del comportamento alimentare al “Codice Lillaâ€. Ecco i Documenti del Ministero
Saper accogliere e riconoscere i pazienti affetti da disturbi alimentari, per indirizzarli verso il giusto percorso terapeutico: è questo il contenuto di due documenti emanati dal Ministero della Sanità, che istituisce per la prima volta un codice ad hoc: il codice Lilla.
I disturbi del comportamento alimentare più diffusi e conosciuti sono anoressia, bulimia e binge eating (disturbo da alimentazione incontrollata che porta all’obesità).
In Italia ne soffrono più di tre milioni e mezzo di persone, con 8.500 nuovi casi all’anno, di cui il 10% sono maschi.
Una malattia esplosa negli anni novanta e della quale si muore, gli ultimi dati istat relativi al 2016, parlano di 3.240 vittime.
Oggi, negli Stati Uniti, sono la prima causa di morte per malattia mentale.
Due i documenti elaborati dal Ministero della Salute:
-
“Raccomandazioni per interventi in Pronto Soccorso per un Codice Lilla”
-
“Raccomandazioni per i familiari”.
“Raccomandazioni per interventi in Pronto Soccorso per un Codice Lilla”
E’ un vero e proprio manuale per gli operatori sanitari: 12 pagine che illustrano la patologia, la classificazione, i principali comportamenti di chi ha un disturbo alimentare, gli indici per stabilire la gravità dello stato del paziente, i criteri di ammissione al ricovero ospedaliero.
Uno dei ruoli centrali è quello dell’infermiere:
Per un percorso clinico-assistenziale completo ed efficace fondamentale è il lavoro in team tra le diverse figure professionali.
Indispensabile, nell’ambito del processo di triage, la presenza di personale infermieristico adeguatamente formato, la cui esperienza e specifico training consentano non solo la raccolta dei dati e l’identificazione dei bisogni di salute della persona, ma anche il possesso di capacità relazionali e comunicative necessarie all’ascolto, al sostegno emotivo e alla costruzione di un rapporto di fiducia reciproca, al fine di far sentire davvero paziente e familiari in
una situazione di collaborazione ed appoggio.
• È consigliabile, quando possibile, ascoltare le informazioni fornite dai parenti (o altri eventuali accompagnatori), sia nei minori, ma anche nei maggiorenni quanto vi sia una scarsa collaborazione da parte del paziente (secondo e compatibilmente alla normativa sulla tutela della privacy).
• Il medico del Pronto Soccorso dovrebbe vedere il paziente adulto da solo e, nel caso sia un minore, chiedere ai genitori di poterlo fare con il loro consenso.
• L’approccio individuale con il paziente facilita l'esplorazione della sua prospettiva sulla consultazione e sulla natura del suo problema, e getta le basi per lo sviluppo di una relazione terapeutica collaborativa. Con gli adolescenti va comunque sempre eseguito un incontro congiunto con il paziente e i genitori per chiedere il loro consenso informato sulle procedure diagnostiche e terapeutiche da intraprendere.
• Un'altra strategia, che può aiutare a ingaggiare il paziente, in particolare gli adolescenti, consiste nel sottolineare che l’esclusiva preoccupazione del medico sia il suo bene e non quello di altri, e che egli opererà solo per conto suo e non dei genitori e di altri significativi.
• È utile, quando possibile, contattare il medico o il pediatra curante o gli specialisti che hanno in cura il paziente, in particolare quando si pongano ostacoli ad una corretta valutazione del quadro clinico.
“Raccomandazioni per i familiari”.
In questo secondo documento si pone l’attenzione all’attenta descrizione della patologia e di forniscono risposte a quelle che sono le domande più frequenti, come i più comuni sintomi del disturbo alimentare o come gestire il momento del pasto.
I documenti del Ministero della Sanità:
Documento per operatori sanitari.pdf
Raccomandazioni per i familiari.pdf
articoli correlati:
Istigare alla magrezza diventerà reato. La proposta di legge
da QS

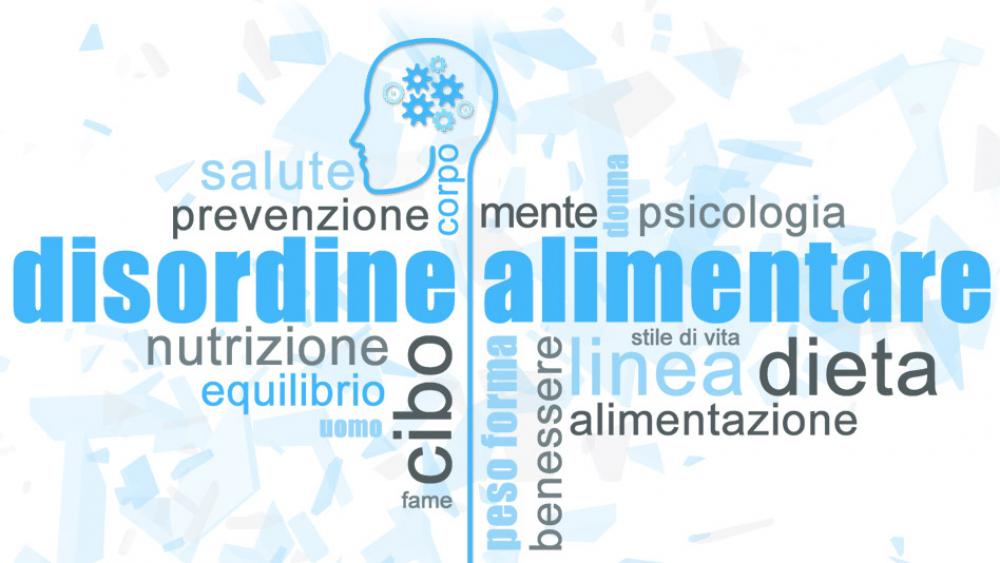
 di
di